Traduzione dall’arabo a cura di Federica Pistono

Aveva sedici anni. Era esile, vestita tutta di viola. Le tremavano le gambe.
Lei e Mansur, suo padre, avevano una parentela che non comprendeva donne. Così, era toccato a lui vestirla, in quell’occasione. Durante il pranzo, Fatma avvertì il distacco paterno. Si rese conto che quell’uomo, suo padre, era l’ultimo della sua stirpe. Aveva sessantotto anni, forse settanta, ma aveva realmente vissuto solo due o tre anni della sua esistenza. Il suo gusto per la solitudine era così forte da tenerlo lontano dalla vita.
Nella famiglia di Fatma, le donne sopravvivevano agli uomini. Sua nonna, la leggendaria Shumla, era una regina di longevità. Shumla sembrava vivere in eterno, o, almeno, era vissuta abbastanza a lungo da assistere al trapasso di tutti gli uomini della famiglia: dodici fratelli, una trentina di zii, centinaia di cugini, i mariti che aveva sposato, a decine, uno dopo l’altro. Aveva dato alla luce un figlio, il padre di Fatma, quando aveva, secondo un calcolo prudente, circa centocinquant’anni. Il figlio le era totalmente devoto, perfino nei sogni. Il padre di Fatma non si interessava alle donne, ma solo all’anziana madre.
Shumla aveva combinato il matrimonio del figlio, giunto a vent’anni, con una delle sue amiche: la sposa aveva settant’anni. Era morta dando alla luce Fatma, all’età di cent’anni. Nonna Shumla aveva imposto alla bimba il nome di Fatma, che significa “Colei che nutre”, o, in breve, “Colei che ha allattato tua madre fuori di questo mondo”.
Shumla era convinta che Fatma fosse identica, spiritualmente e fisicamente, alla propria madre. «Questo è un errore che non ho mai commesso, con una figlia», si diceva la vecchia. «Permettere a una ragazzina di distruggere una delle nostre donne dalla lunga vita».
Soltanto un anno addietro, Shumla si era arresa alla morte. Fatma non aveva mai capito la passione per la vita che ardeva nelle donne come sua nonna. Confinate nelle loro stanze, non si alzavano più dal letto. Che senso aveva una vita simile? Nonna Shumla era stata una combattente, aveva sempre sfidato la morte, guardandola in faccia. Una cosa, Fatma l’aveva capita: alla nonna piaceva sentir parlare della morte degli uomini. Governava un reame di uomini defunti, nutrendosi della loro morte. Quei decessi erano il suo conforto, il suo sollievo, il suo sostegno in una vita misera e infinita.
Quando la famiglia aveva lasciato la dimora tribale per trasferirsi alla Mecca, Shumla aveva perduto tutto quello che amava. Non aveva più nulla: né un gregge di cui prendersi cura, né campi in cui vagare. Tutto ciò che possedeva, ora, era una stanza simile a una gabbia, all’interno di una casa.
Ogni mattina, stendeva il tappeto più rosso che aveva e teneva corte con le vicine. Una delle donne si era offerta di cucinare per lei, un’altra di pulirle la casa. Le vicine avrebbero fatto qualunque cosa, pur di compiacere quel personaggio regale. Shumla raccontava facezie, distribuiva critiche, elargiva complimenti e, generalmente, dipingeva le donne nella luce migliore. Diceva tutto ciò che le passava per la testa, senza paura di offendere i suoi giovani ammiratori.
Una mattina, aveva annunciato con voce piuttosto spensierata: «Ezrael, l’angelo della morte, dorme sotto il mio letto. È sempre stato lì, lo tengo d’occhio. Lo ingannerò sposando uomini forti».
Le donne avevano sorriso di quello scherzo maligno. Volevano essere amiche di Shumla, perché sapevano che, oltre all’angelo della morte, conservava sotto il letto ogni sorta di talismani. Ogni volta che un problema d’amore si verificava nella vita di qualcuno, l’attempata nobildonna si sedeva e mescolava foglie e polveri magiche in un impasto dall’odore strano. Quelle pozioni non mancavano mai di purificare il cuore e gli altri organi vitali.
«Niente deve bloccare le vie di passaggio dell’amore», ammoniva Shumla. «Il fuoco della passione deve bruciare liberamente, consumarti la carne. Altrimenti, la fiamma si spegnerà e perderai il tuo amato».
Le donne le si avvicinavano, affamate della sua saggezza.
«Non importa il motivo», continuava, «ma non riuscirai a intrattenere un amante, se gli organi non funzionano bene. È una cosa che produce una brutta impressione e indebolisce il desiderio».
Shumla era assolutamente spudorata quando si trattava di discutere di faccende intime. Riguardo alle regole sacre della pulizia, consigliava: «Nulla deve rovinare l’atmosfera, nessun odore sgradevole. Quindi, fa’ attenzione a quello che mangi. Ciò che ingerisci dovrebbe esaltare il tuo profumo puro e naturale. Devi pensare al tipo di fragranza che piace al tuo amante – per non parlare di altre attività-, e imparare alcune cose, che potrai usare come armi. Approfittane, e cerca di variare la scelta delle tue armi. Ricorda, esistono delle regole in questa diversificazione. Gli animali ricorrono all’istinto per marcare il territorio con il respiro, il sudore e l’urina, qualunque cosa abbia il potere di segnare il terreno. Questo vale anche per te e i tuoi partner».
Quindi, si ritirava nel suo letto in compagnia di Ezrael, l’angelo della morte.
Un giorno, Shumla era entrata in quello che definiva il suo “periodo di purificazione”. Aveva intrapreso un digiuno, alimentandosi soltanto con il miele di api nutrite esclusivamente di fiori di acacia. Dopo sette giorni, dal suo corpo emanava la fragranza delle acacie selvatiche. La settima notte, Ezrael, l’angelo della morte, aveva lasciato il suo letto. Shumla non poteva sopportare di vederlo andare via. Si era alzata per seguirlo, abbandonando il velo per la testa.
I vicini l’avevano trovata, regalmente seduta sulla biforcazione dei rami di un albero di jojoba, intenta a fissare l’orizzonte, le montagne della sua patria. Quando Fatma aveva scorto l’espressione beata del suo viso, aveva pensato a qualcosa che la nonna era solita ripeterle, respirando la prima brezza del mattino: «Annusa le acacie. Nel profumo, c’è il richiamo delle montagne di Shummer».
Mattina e sera, Fatma sedeva per ore con la nonna, in attesa di captare la fragranza delle acacie. Le guance di Shumla erano incorniciate da riccioli neri, che danzavano nel vento saturo di odore di acacia: la fragranza che era in lei andava a incontrare il vento. Le montagne di Shummer, raccontava la nonna alla nipote, si innalzavano a nord, molto, molto lontano, in due grandi catene parallele, l’una chiamata Aja, l’altra Sulma. Aja e Sulma erano una famosa coppia di amanti, fuggiti dalla tribù- la stessa tribù di Shumla -, per poi essere catturati e uccisi, quindi trasformati in gigantesche montagne. Così gli amanti sarebbero rimasti per sempre l’uno davanti all’altra, cantando canzoni al passaggio di venti e ombre sopra di loro.
L’espressione gioiosa di attesa, che si dipingeva sul viso di Shumla quando raccontava questa storia, era la stessa che le appariva sul volto quando intratteneva i pretendenti. Era l’espressione di una gran signora, destinata a raggiungere la terra dell’amore eterno.
Shumla aveva fatto in modo di lasciare questo mondo in modo semplice e pulito, come aveva fatto quando ci era entrata. La fragranza di acacia era molto intensa, quando i vicini avevano trovato il suo corpo, tutto vestito di verde, adagiato su una lastra di pietra. Si era finalmente liberata del peso dell’esistenza. Aveva portato con sé tutte le sue pozioni e le sue formule segrete, accentuando il senso di vuoto dopo la sua dipartita. Nel letto di tutti gli amanti, si avvertiva la mancanza dei suoi consigli.
Quel giorno, Mansur, il padre di Fatma, tornò a casa dopo pranzo. Le mani di Fatma grondavano acqua dei piatti, quando gli aprì la porta. Il padre fissò le mani come se quell’umidità fosse indice di una vitalità eccessiva.
«Va’ a fare una doccia», le disse con voce piatta. Pareva, parlando, alleggerirsi di un peso.
Fatma riuscì a stento a controllare una smorfia ironica; il padre non le aveva mai detto una cosa così intima.
«Mettiti qualcosa di nuovo», continuò. «Qualcosa di carino». Ora, sembrava annoiato. Fatma cominciò a provare interesse. «Sei abbastanza grande per sposarti», aggiunse. «Rimandare non avrebbe senso».
Uscì.
Tornò in compagnia di un giovane, la cui presenza riempiva la piccola stanza, pur non facendo altro che guardarsi i piedi. Fatma rimase lì, agghindata per l’occasione, seduta per tre ore. Era pronta per il finale della storia. Ogni volta che sbirciava il giovane, tutto vestito di bianco, quello era intento a fissare il pavimento. Anche il padre faceva la stessa cosa. Soltanto Fatma, la ragazza sedicenne, sembrava assaporare un momento delizioso. Le piaceva l’idea di un cambiamento improvviso, drastico. In qualche modo, sapeva che il destino non le avrebbe offerto una tregua con la vita. La piccola “nutrice” Fatma, nipote della Regina della Longevità, era come un’ape, pronta a prendere il suo posto nell’alveare.
Guardò il bel giovanotto – aveva i baffi più scuri che avesse mai visto-, e rabbrividì. Il tremore scurì le pieghe dell’abito viola. Che cosa stavano aspettando? Il crepuscolo cedeva il passo alle tenebre. La sua pelle divenne più morbida.
Qualcuno bussò alla porta. Il padre di Fatma sospirò di sollievo, grato dell’interruzione. Si voltò bruscamente, segnalando a sua figlia di lasciare la stanza: sarebbe rimasta in cucina, mentre lui avrebbe ricevuto i visitatori. Quando si alzò per andarsene, la ragazza avvertì una scossa. Il giovane la stava guardando. Tirò indietro la pancia, raddrizzò il collo, il busto e i seni. Gli occhi del giovane vagavano sul suo corpo. Fatma si voltò, affrontando il suo sguardo. Rischiando di rovesciare il contenuto del suo bicchiere, lui continuò a sbirciarla, paralizzato dall’agilità del corpo della ragazza.
Per un minuto infinito, mentre il padre era girato, il giovane continuò a fissarla. Fatma non riusciva a guardarlo negli occhi. Quando, infine, arrivò in cucina, stava tremando.
Le voci degli uomini giungevano chiaramente dalla stanza accanto. Era strano udire qualcuno parlare, in una casa quasi sempre vuota. Uno dei tre, uno sheikh, stava leggendo un contratto matrimoniale. Le altre due voci, quelle del padre e del giovane, rispondevano allo sheikh, come testimoni del contratto.
Fatma sedeva su uno sgabello basso, sentendo il suo destino legarsi in nodi stretti. Il suo vestito si allargava come una pozzanghera sul pavimento di nudo cemento. Teneva la testa alta ma, con la pancia, sembrava sprofondare nel pozzo dell’universo.
Restò in ascolto per diversi minuti, anche se, ben presto, perdette il senso di ciò che le voci stavano dicendo. Era concentrata su un’antica urna d’ottone, l’unica decorazione della casa. L’urna era abbastanza piccola da essere racchiusa in una mano, era decorata con immagini dei Sette Cieli, cieli intarsiati con cavalieri d’argento che danzavano e combattevano in varie pose. I corpi dei cavalieri, per metà uomini e per metà uccelli, accesero di calore le guance e le mani di Fatma. Durante l’infanzia e l’adolescenza, quei cavalieri erano stati i suoi soli amici.
Per Fatma, rappresentavano l’incarnazione stessa del potere. Teneramente, per l’ultima volta, li sfiorò.
Erano vivi. La piccola urna sembrava ruggire, lanciando clamori di guerra e grida di gioia. I cavalieri ondeggiavano sull’urna, danzando e combattendo, muovendosi rapidi o lenti, poi di nuovo veloci, corpi flessuosi eppure minacciosi, figure pulsanti, stagliate sullo sfondo luminoso della tenda. La tenda era sempre stata lì, velava la finestra fin da quando Fatma poteva ricordarsene.
Con un dito, rimosse i granelli di polvere e le gocce di sudore dei cavalieri. Quando li toccò, brillarono come un fulmine, un fulmine che la colpì. Si sentiva incredibilmente viva. Sorrise confusamente, concentrandosi su una figura squisita, che stringeva una bandiera in una mano e la coda di un leone nell’altra. Il leone era ritto sulle zampe, simile a una nuvola, sovrastando i cavalieri. Fatma aveva solo tre anni, quando aveva saputo che il nome del cavaliere portabandiera era Nur. Accarezzò con il dito il leone rampante.
Suo padre entrò in cucina. Fatma fu strappata al suo sogno; aveva le guance viola come il vestito. In casa, le disse il padre, era rimasto soltanto quello che era ormai suo marito. Quando Fatma tornò nella stanza, lo sposo la scrutò seriamente, quasi offeso dal suo aspetto sognante.
Era dovere di Fatma andare con lui nella nuova casa. Intontita, si avviò verso la porta della casa paterna. Mansur le consegnò un dono di nozze, un’abaya nera. Il cappuccio era intessuto così finemente che, per un attimo, Fatma pensò che suo padre avesse voluto usarle chissà quale delicatezza. Invece, si trattava soltanto dell’abaya di sua nonna. Suo padre stava rispettando il desiderio di Shumla, che aveva lasciato l’indumento alla nipote.
La seta era una carezza sulle sue mani. Stava per esaminare il tessuto più da vicino, quando si accorse di essere di nuovo sola. La solitudine era il sentimento che, più di ogni altro, le era familiare, l’essenza stessa della sua vita.
Ricordava l’abaya fin dai giorni più remoti della sua infanzia. Era l’oggetto più prezioso, nella cassapanca di legno di sua nonna. Non aveva più lasciato il fondo della cassapanca, non era stato più osservato, né toccato, non aveva più visto la luce

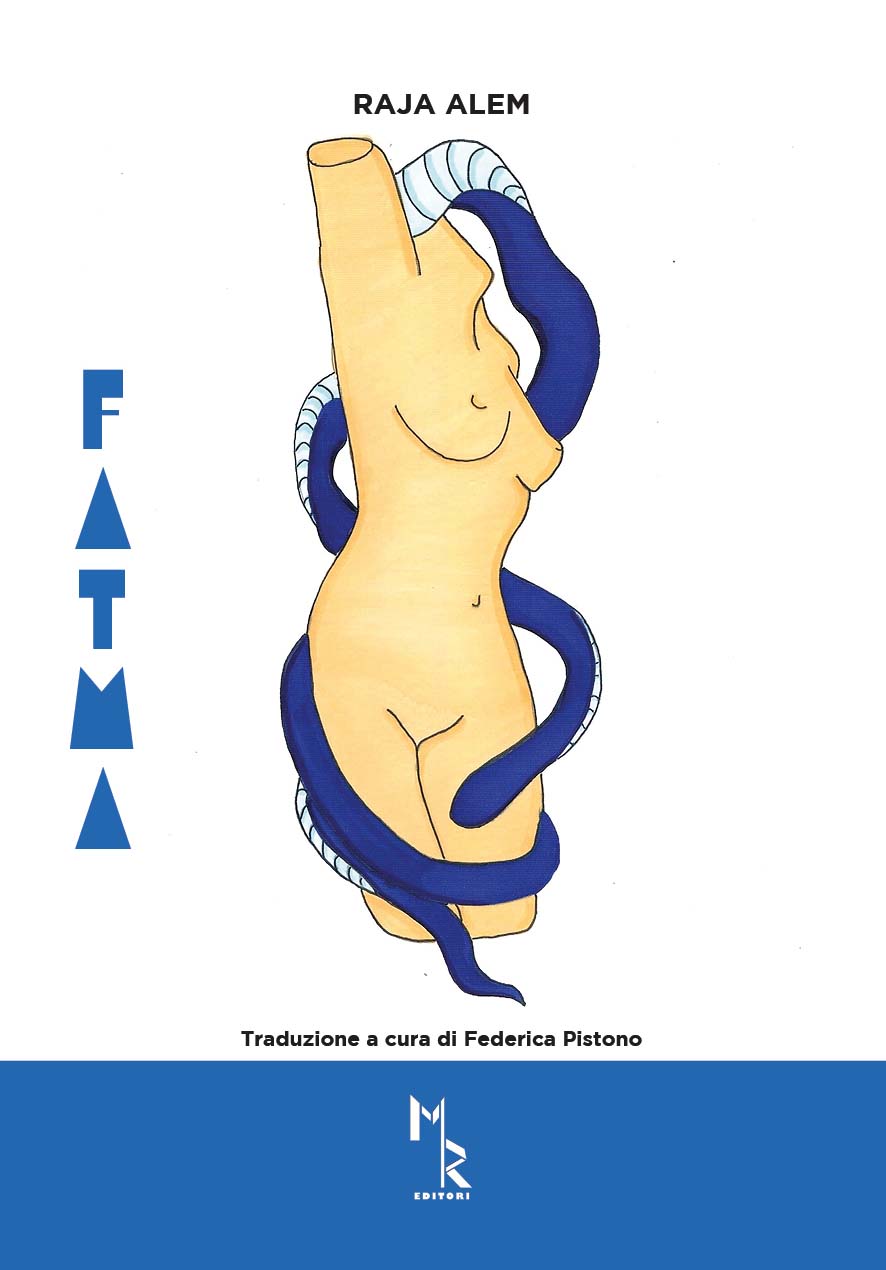
Rispondi